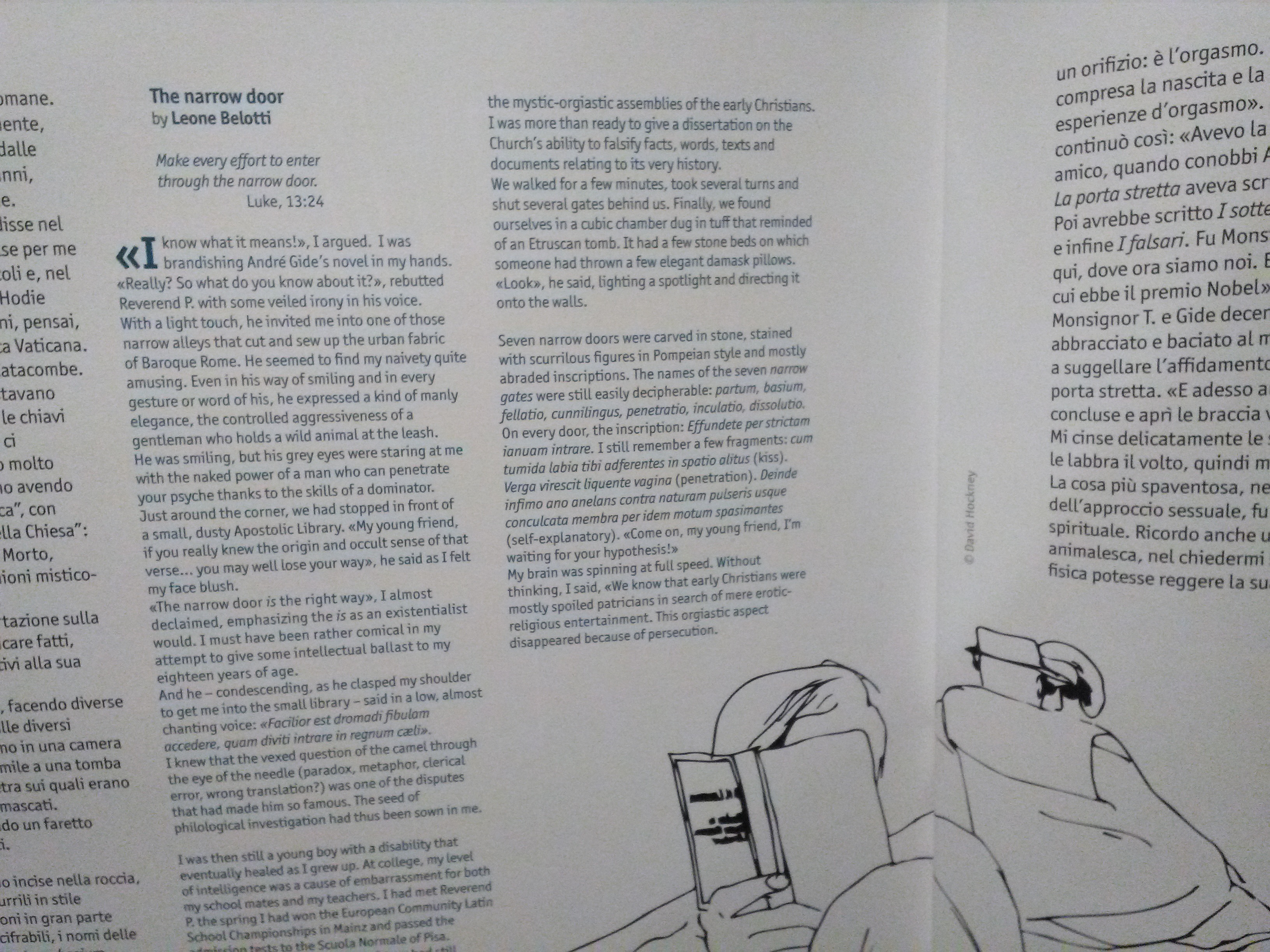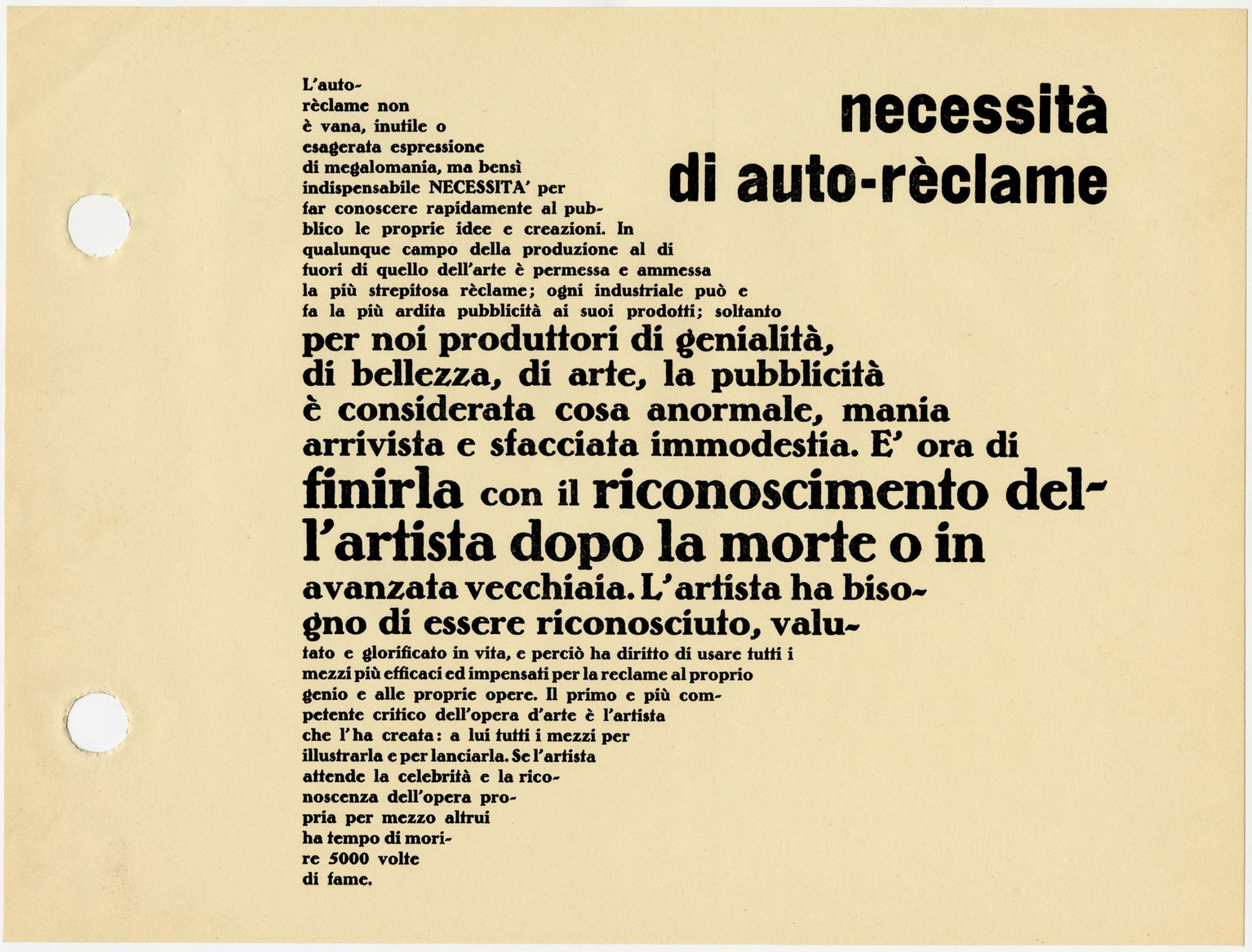play this post

Tre di notte. L’auto è una vecchia e anonima Fiat bianca, con il motore potenziato. Soltanto una minuscola targhetta metallica la rivela come appartenente alla Questura. Corre veloce oltre l’Oriocenter e l’aeroporto, sottopassa l’autostrada A4, la grande arteria, e si getta nel muro di nebbia. Al volante una donna dal viso segnato, gli occhi neri, le labbra carnose, niente trucco, capelli corti e un corpo giunonico che i jeans e il giubbino di pelle non riescono a nascondere.
Prende una strada tra i campi, supera la roggia, rallenta. Il capannone del birrificio appare dal nulla, un’astronave con gli oblò illuminati. Spegne il motore, prende la sua vecchia borsa di cuoio, gonfia di incartamenti, scende, spinge il portone scorrevole, entra. «Ciao birraio!», si annuncia.
In cima a una scaletta che corre sopra i fermentatori, appena sotto il tetto del capannone, in salopette e stivali, compare il birraio.
«Ciao Rosa.»
L’ispettore Rosaria Schillaci sorride, e non le capita di frequente. Molla la borsa su un tavolaccio.
«C’è qualcosa da bere?»
Il birraio scende dalla scaletta. «Sette od otto mila litri di birra dovrei averli.»
Le serve una birra scura, densa, speziata, eretica. Si guardano. Lei è meridionale, funzionario pubblico, due lauree, una vita zingara, un sfilza di trasferimenti per “incompatibilità ambientale”. Lui è un artigiano del nord, senza titoli scolastici, radicato nella sua terra. Hanno una sola cosa in comune: l’amore per il proprio lavoro. E un certo sentimento da cani sciolti che li unisce al di là di tutte le differenze.
«Racconta.», le dice.
Lei si slaccia il giubbino, apre la borsa, ne estrae un grosso faldone. Sono diventati amici quasi per caso, e si sono subito piaciuti e ritrovati con un’intesa tutta psicologica, come due fratelli, senza la minima traccia di attrazione erotica. L’ispettore non ha famiglia né marito, e nemmeno amiche o amici. In compenso, si è fatta molti nemici. Non si fida dei colleghi, e nemmeno dei magistrati. Il birraio è uomo di poche parole, ma sa ascoltare.
L’ispettore apre il faldone, da una busta tira fuori alcune foto.
«Giulia Bonomelli, 16 anni, studentessa modello del liceo classico, famiglia molto nota, e molto agiata.»
Il birraio prende in mano la prima foto. «Ne dimostra di più. Ma… è davvero bellissima!»
«Era bellissima, è morta. Quella che stai guardando è una foto di sei mesi fa. Questa è più recente, e questa dell’anno scorso.»
Solo adesso il birraio nota che la busta dalla quale Rosa ha preso le foto ha un’etichetta con scritto “la vittima”.
«Qui è ancora una bambina», dice guardando la prima delle tre foto. Lo deduce dallo sguardo, dai lineamenti, dalle forme acerbe. Poi prende la più recente. Il sorriso solare è scomparso. Una magrezza eccessiva, da anoressia. La pelle tirata, le occhiaie.
«Qui è già vecchia. Cosa le è successo?»
«Aspetta.» risponde Rosa, e tira fuori la seconda busta, con la dicitura “indiziati”.
Sono parecchie immagini, ritratti di professionisti di successo, foto di gruppo di staff aziendali.
«Chi sono?»
L’ispettore glieli indica uno per uno, nomi e cognomi, incarichi e ruoli. Si tratta di due gruppi distinti di persone. Nel primo gruppo ci sono gli azionisti di maggioranza di tre grandi e noti marchi multinazionali: una casa di moda, una farmaceutica, una liquori e bevande. Nel secondo gruppo i responsabili comunicazione delle suddette aziende, e i creativi delle agenzie pubblicitarie che lavorano per loro. Il birraio conta 35 persone.
«Spiegami. Cosa hanno fatto?»
«Aspetta, ho bisogno di un’altra birra.»
Senza proferire parola, il birraio apre un piccolo fusto da 5 litri senza etichetta e spilla due boccali. Bevono.
«Buona. Che cos’é?»
«Non lo so nemmeno io. Non ha nome. Volevo provare alcune combinazioni. Non so nemmeno se la metterò in produzione, non riesco a capire se è finita così, o manca qualcosa…»
Rosa riprende il boccale e con un lungo sorso lo vuota.
«Direi che è finita!», dice. E mentre il birraio le rabbocca il bicchiere, prende la terza busta, che reca l’etichetta “corresponsabili”. Contiene solo due foto. La prima è la classica foto d’inizio anno scolastico, tutta la classe, alunni e docenti.
Il birraio osserva e nota che i volti di tre ragazzi e tre ragazze sono stati cerchiati in rosso, ed anche una docente.
«Non c’era bisogno di segnarli» dice. Sia i tre maschi che le tre femmine hanno qualcosa che li fa spiccare dai loro compagni.
«Perchè?»
«Sono più scafati. Più maturi. I loro compagni sono ancora bambini, questi sono già adulti. Fanno sesso, forse hanno già provato le droghe, o forse sono semplicemente molto più figli di papà dei loro compagni»
«Bravo.»
«E la profe?»
«Non è una professoressa qualsiasi. La psicologa della scuola.»
«Va bene, adesso raccontami la storia.»
Rosa annuisce.
«Si, ancora una cosa, poi ti espongo la mia ricostruzione»
Nel faldone c’è un’ultima busta. “La famiglia”. Una sola foto. Sul ponte di una vecchia barca a vela, la famiglia Bonomelli.
«Questa è Nora, la madre, bella e altera, ex modella, lo stesso viso della figlia Giulia, come vedi; il fratello più piccolo, Federico, biondo e impassibile, come il padre Giangiacomo, commercialista di primissimo livello, con denuncia dei redditi superiore al milione, e una lista infinita di partecipazioni azionarie e proprietà immobiliare. Collezionista di auto sportive d’epoca, buon tennista.»
Il birraio posa la foto sul tavolo. Dice: «bella famiglia.»
«Già. La storia per un certo verso è molto semplice, per un altro molto complessa. Giulia è stata violentata e uccisa, e non da una sola persona, ma da più soggetti, e i colpevoli sono da identificare nel gruppo degli indiziati e dei corresponsabili.»
«Violentata e uccisa?»
«Si, ma non è così semplice.»
«Abbiamo tutta la notte.»
«La storia inizia nella primavera dello scorso anno, quando il gruppo Jeunesse rileva dal gruppo BonTon il marchio Louisel.»
Sul tavolo ora ricompaiono le foto degli uomini della casa di moda: azionisti di maggioranza, stilista, art director, fotografo e copy writer dell’agenzia pubblicitaria.
«Il marchio Louisel è sempre stato la griffe di punta delle adolescenti acqua e sapone, per bene, con qualcosa di antico, della nonna, maglieria pastello, gonne a quadri, un po’ british, collegiale, insomma la divisa delle ragazzine bene.»
«Tu vestivi Louisel?»
«Io sono cresciuta in orfanatrofio, amico mio, e vestivo solo Caritas!»
«Che fa sempre tendenza!»
Ridono insieme, brindano. Anche il birraio è cresciuto in orfanatrofio.
«E allora?»
«E allora a un certo punto il gruppo Jeunesse decide di acquisire Louisel per fare un’operazione commerciale molto “coraggiosa”, così almeno hanno scritto le più famose giornaliste di moda.»
«E cioè?»
«Hanno presentato una nuova collezione, ma soprattutto una campagna pubblicitaria pervasiva al limite della denuncia per oltraggio al pudore. Le ragazzine bene che da due generazioni incarnavano la griffe Louisel sono diventate da un giorno all’altro, nei poster e negli spot, nelle pagine dei magazine di moda femminili, delle dark lady, delle femme fatale supersexy, supermagre, in ambienti superlusso, bui e fumosi, circondate da alcolici, gioielli, in pose lascive, lunghe gambe larghe, sguardi spenti o persi nel vuoto da tossicodipendenti…»
«Ho presente, anche io sono rimasto colpito da quelle immagini. Il prodotto reclamizzato era il sesso, o forse anche la depressione…»
«Hai ragione. Ma ha avuto un grande successo. Fatturato triplicato, e tutta la stampa a osannare questi tizi come fossero dei geni.»
«E cosa c’entra la nostra ragazzina?»
«La nostra ragazzina ha fatto parte del casting della nuova campagna.»
«Ah! Dunque era lei su quei manifesti…»
«No, lei faceva parte del cast, è apparsa nei servizi sui settimanali, ma di contorno, in secondo piano, non ha avuto la parte della protagonista, e non appare nelle foto scelte per le pagine pubblicitarie sui grandi quotidiani e sulle affissioni che hanno tappezzato l’Italia la scorsa primavera.»
«E come ha fatto una ragazzina di 15 anni a entrare in quell’ambiente?»
«La madre, è stata la madre a mandarla all’agenzia di modelle, una delle più grandi, la stessa per cui lei ha lavorato negli anni novanta, prima di sposarsi.»
Ora guardano insieme la foto di famiglia, osservano la linea perfetta della figura, il seno evidentemente rifatto, ma alla perfezione, così come le labbra.
«La madre», commenta il birraio, e poi ripete «la madre», con la voce spenta, priva di tono, che pure dice tutto, come una campana a morto.
«Già, la madre» riprende l’ispettore «la madre che, dopo che Giulia non è stata scelta come guest model della campagna, ha fatto alla figlia una scenata, culminata con “te lo dico io perchè non ti hanno scelto, non gliene frega un cazzo se tu sei la prima della classe in greco e latino, e non gliene frega un cazzo se non sai fare la faccia da troietta, te l’avrebbero insegnato, e te l’avrei insegnato io: il motivo per cui ti hanno scartata è questo! e solo questo!” e intanto le prendeva, e le strizzava con forza, con rabbia, le cosce, la pancia. Questo almeno a dare retta al racconto della governante. Da quel momento, Giulia ha iniziato a diventare anoressica. La psicologa della scuola invece sostiene che Giulia ha smesso di mangiare in seguito al “trauma” che le è capitato poco dopo. Ma c’è anche una terza spiegazione. Che viene dalla segretaria del padre, la quale mi ha riferito un fatto che ribalta tutto. Pare sia stato il padre a… »
Il cicalio di una suoneria interrompe il resoconto dell’ispettore.
«Scusa un minuto, anzi: seguimi», dice il birraio.
«Sissignore!»
«Prendi uno di questi sacchi, e fai quello che faccio io.»
Salgono su una passerella, e svuotano lentamente, a pioggia, il sacco di luppolo nell’ammostatore. Poi il birraio compie una serie di gesti, manovra una serie di leve.
«A posto.», dice, e tornano al bancone di mescita.
«Il padre» dice il birraio, mentre spilla altre due birre.
«Il padre è stato avvertito da qualcuno dell’agenzia che sua figlia rischiava di diventare una lolita da copertina, ovvero che lui rischiava di aver problemi di reputazione, dal momento che metà dei suoi clienti sono istituti religiosi.»
«E quindi ha fatto due telefonate e la figlia è stata scartata.»
«Esatto. Ma adesso veniamo al “trauma”, per usare le parole della psicologa. Gita scolastica. Cinque giorni a Berlino.»
«A Berlino?»
«Si, con la scusa del festival del cinema. E qui tiriamo fuori la seconda multinazionale, quella degli alcolici.»
«Penso di aver capito… »
«Anche qui, grandi studi, indagini di mercato, progetto d’immagine geniale, social marketing, eccetera eccetera, ed ecco che questa bevanda, e i vari long drink e shoot dedicati, diventa il nuovo culto dei teen-ager, delle ragazze soprattutto, per l’ebbrezza facile.»
Il birraio adesso prende la foto di classe, osserva i volti dei ragazzini contrassegnati dal cerchio rosso.
Dice: «Un’orgia in gita scolastica.»
«Peggio, uno stupro di gruppo. Certo erano tutti ubriachi, forse anche fatti di cocaina. Giulia praticamente collassata, al pronto soccorso l’hanno letteralmente richiamata dalla morte, è rimasta in coma due giorni.»
«Erano questi sei?»
«Si, avevano deciso di fare un festino privato in camera delle tre ragazze.»
«E come si è saputo dello stupro?»
«Aspetta. Una settimana dopo il ritorno dalla gita Giulia ha cominciato a vomitare. Era incinta. La madre si è infuriata, e più la madre si infuriava – riferisce la governante – più Giulia le negava quel che lei pretendeva di sapere, cioè come fossero andate le cose, chi fosse il padre. La madre dava per scontato che l’accaduto fosse colpa di Giulia, della sua sprovvedutezza in fatto di contraccezione.»
«Quindi non ha raccontato alla madre quello che era successo?»
«No: ha fatto ben altro. Ha preso carta e penna, e ha scritto tre lettere, ai genitori dei suoi tre compagni di scuola, dove raccontava di essere stata fatta ubriacare e poi violentata dai loro figli, aiutati dalle due amiche, che lei era incinta, che aveva intenzione di tenere il figlio, e che chiedeva il versamento di un assegno mensile alle tre famiglie per i prossimi diciotto anni. Aveva intenzione di andare a vivere da sola, secondo la governante, e le aveva persino chiesto la disponibilità a passare alle sue dipendenze!»
«Cristo!»
«I tre padri di famiglia, due avvocati e un architetto, sono andati a parlare col padre di Giulia: che è anche il loro commercialista.»
Il birraio alza gli occhi. Il grande orologio da stazione indica le cinque.
«Scusami Rosa, dobbiamo fare una pausa. Mezz’ora. Fai un pisolino da soldato.»
Si alza, e se ne va a curare le sue birre.
Rosa si allunga sulla panca, s’infila la borsa sotto la testa come un cuscino, e chiude gli occhi.
Da tre settimane questa ragazzina che non ha mai conosciuto, se non su un tavolo d’obitorio, la accompagna in ogni momento della giornata. Ha dedicato a questa indagine “risorse ingiustificate”, come ha detto il suo superiore. Ha parlato con tutti i ragazzi, con i professori, con i genitori, la governante, la segretaria del padre, l’amante del padre, l’amante della madre. Ha letto tutti i diari di Giulia, ha scaricato, stampato e letto tutta la memoria del computer e del telefonino di Giulia, tutti i messaggi, le pagine facebook di tutti i ragazzi.
E sempre quel volto solare, da principessa, davanti agli occhi. Si addormenta profondamente, e si risveglia improvvisamente. Davanti a lei il birraio sta ridendo.
«Rosa! Russi come un orso!»
«Colpa delle tue birre.»
«Sono le sei. Caffettino al bar qui dietro?»
«Sarà meglio.»
Escono dal capannone, s’incamminano tagliando per i campi, raggiungono il piccolo paese, alcune vecchiette entrano in chiesa, davanti al bar ci sono un paio di furgoni da muratori. Entrano. Dietro il banco c’è un cinese. Sorseggiano senza mettere lo zucchero. Si guardano. Il birraio dice: «Fa schifo al punto giusto», e Rosa è d’accordo.
Escono dal bar, tornano al capannone. Attorno a loro i campi sono gelati e immersi nella nebbia. Da qualche parte un cane abbaia stancamente.
«L’ha trovata la governante, un sabato mattina di tre settimane fa, quando è rientrata a casa dopo essere stata a fare le spese. La madre era al centro estetico. Il padre al circolo del tennis, o almeno avrebbe dovuto, in realtà era con l’amante al lago. Il fratello a scuola. Giulia da qualche giorno era a casa in malattia. Quando la governante l’ha trovata aveva un cuscino sul viso, un flacone di Morfeinol vuoto sul comodino, e una bottiglia di vodka vuota sotto il letto.»
Il birraio si ferma. Guarda l’amica.
«So cosa stai pensando. Anche il medico, quando la governante gli ha detto che l’aveva trovata col cuscino sul viso, si è posto la domanda. E quindi ci ha chiamato, e l’indagine è partita da lì, e il magistrato ha disposto l’autopsia. Appena arrivati i referti autoptici, l’indagine è finita, o meglio avrebbe dovuto essere finita, ma io l’ho portata avanti, ma adesso devo proprio chiuderla, “non un’ora di più” mi ha minacciato ieri sera il grande capo, “o ti devo sospendere”. E adesso sono qui a parlarne con te.»
«Rientriamo», dice il birraio. Davanti al capannone adesso ci sono le auto dei ragazzi che attaccano il primo turno.
«Andiamo in ufficio. E cosa ha detto l’autopsia?»
«La morte è da ascriversi al cocktail di medicinali e alcolici, su un fisico debilitato da uno stato ormai cronico di anoressia. Nessuno le ha premuto il cuscino sul viso, se non lei stessa. Sul suo diario ha scritto: oggi è previsto il parto. Come avrai già immaginato, dopo la sua iniziativa di scrivere ai nonni del bambino, Giulia fu affidata a un grande strizzacervelli, da 1000 euro l’ora. Poi mandata in una clinica in Inghilterra ad abortire. Poi di nuovo lo strizzacervelli. E a settembre di nuovo a scuola.»
«Come niente fosse?»
«Come niente fosse. Lo scandalo avrebbe travolto quattro famiglie, quattro onorati studi professionali della città bene, e probabilmente anche la scuola. Così, pensando “anche al bene della ragazza”, hanno deciso di mettere tutto a tacere… e per non dare adito a pettegolezzi, hanno deciso che Giulia avrebbe dovuto continuare a frequentare la scuola.»
«Ma…»
«L’hanno stritolata. Immagina le giornate di questa ragazzina, dover stare in quella classe, tornare poi a casa da quella madre. I tre ragazzi e le due ragazze sono stati esemplari, loro sì, non hanno ceduto di un millimetro, hanno sempre dichiarato all’unisono la stessa versione, ovvero che era stata Giulia quella che li aveva portati a bere fino a perdere il controllo, che era stata Giulia a voler fare sesso con tutti, e che a quel punto le due ragazze erano crollate a dormire, e di fatto non potevano dire di aver visto come fosse andato il rapporto sessuale. Come elemento a sostegno della loro versione, hanno portato l’abbigliamento che Giulia sfoggiava quella sera: il completino sexy Louisel, proprio quello della famosa pubblicità. Hanno negato di aver costretto Giulia a bere, e di averla tenuta ferma mentre i ragazzi la violentavano.»
«E tu non hai prove, ma sei certa che mentano.»
«Esatto. Non ho le prove. Come non ho le prove, anche se le ho, per considerare questo suicidio come un omicidio, e per attribuirne la responsabilità a tutti soggetti che abbiamo visto, le multinazionali che prosperano veicolando falsi miti, i compagni di scuola, la famiglia. Io li ritengo colpevoli di omicidio, tutti»
«Hai ragione.»
«Quando Giulia è tornata dalla clinica dove è stata mandata ad abortire in gran segreto, la madre ha cominciato a darle una serie di psicofarmaci della peggior specie, prodotti di cui lei abusa da dieci anni.»
«E con ciò arriviamo alla multinazionale farmaceutica.»
«Si.»
«…»
«Lo so, amico mio, è una storia triste.»
«Molto triste.»
«E il mio capo ha ragione, non posso sbattere in galera questa gente, anche se mi piacerebbe moltissimo.»
«Anche i genitori?»
«Soprattutto i genitori.»
«Cosa vuoi fare, allora?»
«Non c’è niente che possa fare. Devo chiudere quel faldone, e “andare a catturare un po’ di ladri di rame nei cantieri”, come mi consigliano i colleghi, “per il mio bene”. Ma mi sento addosso questa ragazzina che mi chiede: tutto qui?»
Dal campanile del paesino, arriva il rintocco delle campane.
«Le sette», dice il birraio.
«Ora che vada», dice l’ispettore, e raccoglie le foto nelle buste, le buste nel faldone, e i faldone nella borsa.
Il birraio la guarda.
«Rosa, mi dai un passaggio in città?»
«Certo.»
Poco dopo sono sull’asse interurbano. La nebbia si è diradata. Il traffico è già intenso.
«Dove è sepolta?»
«Al Monumentale.»
«Passiamo a darle un saluto?»
«Si.»
Prima di entrare si fermano a comprare dei fiori al chiosco. Il fiorista si sfrega le mani per il freddo.
Mentre si incamminano lungo i vialetti tra i cipressi, Rosa prende l’amico sottobraccio.
«La cosa più triste è stata la messa, c’era tutta la città, tutta la scuola, tutti i notabili, la cattedrale era piena come alla messa di Natale, tutti riuniti per ucciderla tutti insieme per la seconda volta.»
«Perchè dici questo?»
«Ti porterò la registrazione dell’omelia. Per fortuna, come al solito, non avevo con me l’arma d’ordinanza, perchè credo che avrei potuto sparargli, direttamente dal banco al pulpito…»
Improvvisamente è scossa da un accesso di pianto. Il birraio la sostiene. Lei cerca di sdrammatizzare, e ai singhiozzi trattenuti subentra la risata: «Un prete a dieci metri dovrei riuscire a centrarlo!»
Davanti a loro c’è una lapide molto semplice. Sono passate due settimane dal funerale. I fiori sono ormai marci. Il birraio osserva i fiori che hanno portato, un piccolo mazzo di fiori di campo. In un attimo abbranca la massa di fiori marci e li porta nel bidone. Poi sistema il mazzo. Sulla lapide c’è la stessa foto, solo il volto, di Giulia non ancora anoressica, nel suo massimo splendore di principessina.
«Che cosa ha detto nella predica? Perchè gli avresti sparato?», chiede il birraio.
Rosa adesso si è ripresa. Con un cenno gli fa capire che possono andare. O forse non la va di raccontare davanti alla sua tomba quello che ha detto il prete al suo funerale.
Si allontanano.
«Un’omelia capolavoro. Tutta la città in lacrime. Un genio. Praticamente ha dato la colpa al Signore, che l’ha chiamata a sé. Il destino degli angeli!»
«Poveretto, magari non sapeva niente, ed era in buona fede.»
«In buona fede? Lo sai quanto avranno pagato per avere quel funerale? Lo sai che in caso di suicidio l’obolo si moltiplica per dieci?»
«Tu sei anticlericale. Magari riesci a farti trasferire anche stavolta per “incompatibilità ambientale” con la curia.»
«Potrebbe succedere.»
Risalgono in macchina.
«Quindi non ne farai niente?»
«E cosa si può farne? Magari in pensione mi metterò a scrivere, e diventerò una giallista di successo. Ecco cosa posso farne di questa storia, un romanzo!»
Il birraio scuote la testa poco convinto.
«Troppi colpevoli», dice.
FINE