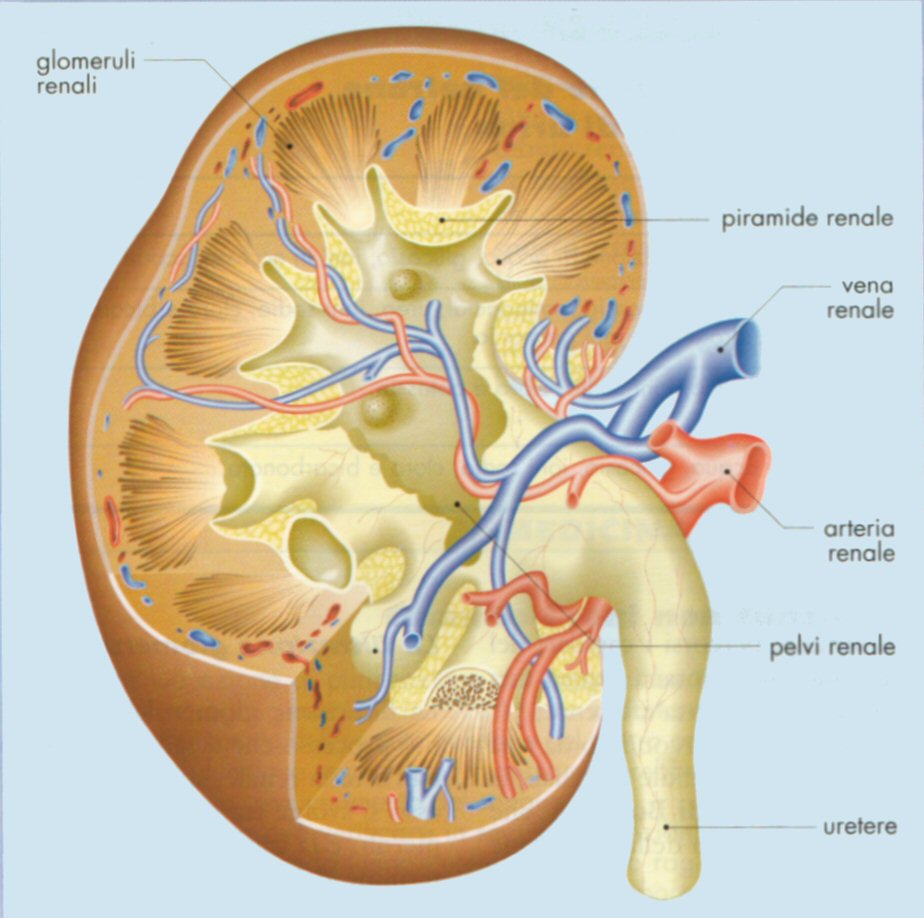play this post

Mio padre lavorava alla Caproni. La Caproni era una fabbrica di aerei. Il campo di prova era appena fuori casa, sulla sponda del fiume. Sentivamo il ruggito dei motori in decollo a tutte le ore. In famiglia eravamo quattro fratelli. Vivevamo a Tresolzio, frazione di Brembate, eravamo mezzadri della contessa Moroni. Il fattore faceva il bello e il cattivo tempo, e aveva anche delle pretese sulle mogli, sulle figlie dei mezzadri.
Eravamo gli ultimi. Chi aveva un pezzo di terra, già era in diritto di trattarci dal di sopra. Andavamo a fare l’erba sul ciglio della strada, ma anche lì c’era qualcuno a dire «non è roba vostra». Tutta la mia infanzia è stata una continua umiliazione.
Mi mandavano in bottega a fare la spesa, c’era sempre qualcosa indietro da pagare, e allora ero sempre l’ultimo, chiunque entrasse era servito prima di me: alla fine dovevo prendere quel mi dava, non potevo scegliere il miglior taleggio, no, quello era per i signori. Questo trattamento lo ricevevi ovunque. Anche a scuola. La maestra per prima cosa guardava come eravamo vestiti, poi decideva i posti. Le prime file erano per i figli del podestà, del’avvocato, del fattore. Poi c’erano i figli dei commercianti e degli impiegati. Nelle ultime file i figli degli operai e dei contadini e in fondo alla classe, nell’ultima fila, nell’ultimo banco c’ero io, il figlio del mezzadro Ravasio.
Il mio primo giorno di scuola finì prima ancora di cominciare: mia nonna mi stava accompagnando, ma suona l’allarme, bombardamenti, tutti a casa, niente scuola.
A sei anni ero già grande, dovevo badare ai fratelli più piccoli, e se succedeva qualcosa ero io responsabile, come quella volta che dovevamo andare da Tresolzio a Locate dalla nonna, e a metà strada sentiamo un rumore che conosciamo bene, aerei, e il mio fratellino Egidio, quattro anni, poer nani, se la fa nei pantaloni, e io a pulirlo in qualche modo, nel fosso, sotto le bombe , e poi, arrivati dalla nonna, le ho dovute anche prendere…
Quando non eravamo a scuola eravamo nei campi ad aiutare, a zappare, a fare il fieno. Si andava a rubare i vecchi stracci per farci un pallone, giocavamo a piedi nudi e ci si faceva male ai piedi, altri giochi non c’erano, qualcuno si divertiva in primavera a costruire arpe con i maggiolini, ma il vero sport era la fionda. Con la fionda in tasca si andava in cerca di qualche passero cui tirare o qualche lampadina, quelle poche che c’erano. Ricordo i miei primi zoccoli di legno, costruiti da mio padre lavorando un pezzo di legno, come ne “L’ albero degli zoccoli”. Per chiuderli si usava un pezzo di copertone usato di bicicletta che aveva già fatto chissà quanti chilometri su strade di ogni tipo e poi ne avrebbe fatti altrettanti a piedi.
A 11 anni ho avuto le mie prime scarpe, in cartone pressato: le ho avuto per andare a lavorare lontano da casa, a Lecco, a far bisacche, le reti metalliche che poi vengono riempite di pietre e usate a irregimentare il fiume. Il filo di ferro di 3 mm, il bordiù, ti tagliava le mani.
Tornando a casa guardavo il fiume in piena, faceva paura, e pensavo: devo farle bene, le bisacche.
La sera mia madre mi diceva «Fammi vedere le mani», e mi curava le ferite.
Questi lavori li facevano i ragazzi, d’inverno, all’aperto.
Finita la guerra, la Caproni decide di lasciare a casa cento operai. Tra questi, mio padre. Un dramma. Con i soldi della liquidazione, per prima cosa, andammo a pagare i debiti col negozio di alimentari. Una scena che mi ricordo come se fosse successa ieri. Ero con mio padre, entriamo, aspettiamo, e quando non c’è nessun altro da servire viene il nostro turno, mio padre tira fuori la grossa banconota da mille lire, sembrava un tovagliolo, gliela consegna, e la signora, che sapeva della liquidazione, nel prendere i soldi, con tono di rimprovero, sollecitava mio padre a darle in consegna tutta la somma, come si farebbe con un bambino. Un’umiliazione terribile. Qualche anno dopo suo figlio, sempre vestito come un damerino, mi passa davanti mentre sto andando alll’allenamento di calcio, e con arroganza volgare lascia andare un peto al mio indirizzo. Alla mia protesta, risponde: «Io mangio il prosciutto, mica la mortadella come voi altri». Senza pensarci, gli sono addosso e gli dò una lezione. Dovevamo avere 14 o 15 anni. Io lavoravo già a Milano, e cominciavo a capire e a non tollerare più certe cose di quel nostro modo di vita da paolot, tutto chiesa, casa e orecchie basse.
Ho sempre avuto la passione per il ballo, una passione iniziata nel dopoguerra, quando lavoravo a Milano, avevo sedici anni, e insieme ad altri compaesani ci fermavamo a dormire dal lunedì al venerdi in una stanza che il titolare della ditta ci aveva dato in uso. Il Giovedì sera si usciva, un’esperienza del tutto nuova per me, andare a divertirsi. Si andava al bar a vedere in televisione “Lascia o raddoppia”, era quello il divertimento. Poi abbiamo cominciato ad andare al Polverone, lo chiamavano così, era uno stanzone sotto la Stazione Centrale addobbato a sala da ballo, frequentato da operai e cameriere. Quando tornavo al paese e dicevo ai miei amici di essere andato a ballare quelli si scambiavano occhiate d’intesa e mi prendevano in giro, erano convinti che raccontassi balle per farmi bello, non potevano capire che a trenta chilometri di distanza, a Milano, certe cose erano normali, c’era il lavoro e la miseria, ma anche un assaggio di una merce che al paese non sapevano nemmeno cosa fosse, la libertà…
Una sera conosco una ragazza, cominciamo a ballare insieme, mi sembra di vivere in un film, poi usciamo, la accompagno a casa in tram, fin sotto il portone dove vive e lavora come cameriera, e lei mi dice: «Vuoi salire a bere una tazza di the? Questa sera i signori non ci sono».
E io, paolot, con in testa il divieto più forte della voglia di stare da solo con una ragazza , che le rispondo: «Allora sarà per un’altra volta». Ci ho poi pensato per settimane, per mesi. Più vista. E un mio compagno di lavoro, uno di Milano, quando gliel’ho raccontata, mi ha detto: «Adesso sai cosa vuol dire pirla».
Qualche anno dopo, salito su un treno, sono andato in Svizzera come edile. Lavoro, lavoro, e ancora lavoro: ma in Italia c’era Liliana, la mia fidanzata. Ci siamo sposati nel 60, e subito a lavorare in Svizzera, ma insieme, lei aveva trovato lavoro nella ristorazione, si viveva con altre cinque coppie di italiani in una casa per emigrati. Facevamo i turni per usare la cucina, ma avevamo la nostra stanza e la sera studiavamo insieme il tedesco.
Poi una notte lei sta male, perde sangue, io nemmeno avevo capito che fosse incinta, per come eravamo stati cresciuti ed educati su certe cose c’era un pudore e un riserbo totale. All’ospedale, insieme al dolore per l’interruzione della gravidanza, mi aspettava un’umiliazione decisiva: un dottore tedesco, in camice bianco e occhiali d’oro, che con disprezzo mi dice: «italiani, siete come gli zingari».
(tratto da Giovan Battista Ravasio, “L’erba sul ciglio della strada”, ©2006 edizioni Calepio Press)